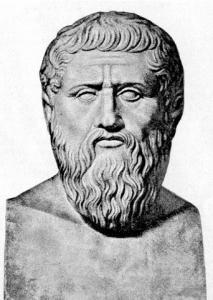In California, puoi uccidere un cavallo per nutrire altri animali, ma non per darlo da mangiare a un uomo. Puoi partecipare al Wife-Carrying World Championship (una curiosa corsa ad ostacoli da fare con la propria consorte sulle spalle) ma, almeno in Francia, non puoi partecipare a una gara di lancio del nano. Se doni un rene salvando una vita diventi un eroe, ma se ti fai pagare diventi un criminale.
Da queste incongruenze, o presunte tali, prende inizio Economists Dissect the ‘Yuck’ Factor, interessante articolo di Patricia Cohen sul New York Times, tutto incentrato sull’analisi economica di quello che potremmo tradurre come “fattore bleah”: certe situazioni ci provocano istintivamente disgusto.
Nell’articolo, l’ultima parola spetta al teologo Michael Novak, che conclude affermando: «mere repugnance is not enough», la semplice ripugnanza non è abbastanza. E su questo, penso, siamo tutti d’accordo.
P.S. Un’altra frase notevole è dello psicologo Paul Bloom: «The problem is not that economists are unreasonable people, it’s that they’re evil people», il problema non è che gli economisti siano persone irragionevoli, è che sono persone malvagie.